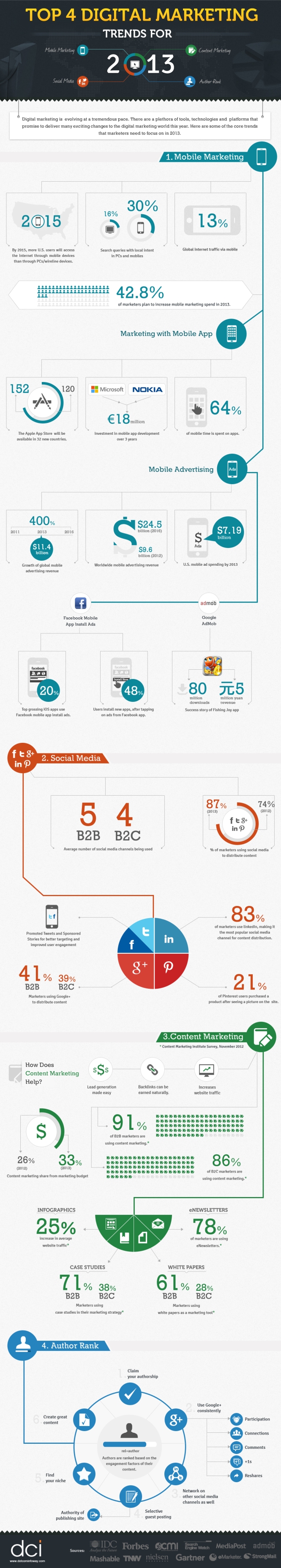Ryan Siegel, con il suo “Are You Ready For Web 2.0?”(Wired 2015) non fu il primo né l’ultimo ‘strillone’ a mettere la propria voce al servizio di quel fenomeno che in molti chiamano ‘la rivoluzione digitale’. A dir la verità, anche se la cosa può apparire quanto meno curiosa, le tappe del fenomeno sono state perfettamente scandite da alcune significative apparizioni sulla copertina del più famoso e tradizionalmente cartaceo numero del Times: quello che ogni anno, puntuale come un orologio svizzero, ci regala una preziosa interpretazione dei tempi che corrono nominando “The Person Of The Year”.
Nel 1982 la nomination va al personal computer, nel 2010 a Mark Zuckerberg e nel 2011 a ‘The Protester’. Un’interpretazione preziosa, dicevo, tanto che va a segnalare proprio quelli che nel sentire comune sono i tre avvenimenti più significativi dell’avvento del digitale inteso come rivoluzione – con tanto di precipitare esponenziale degli eventi verso il finale del racconto –: l’ingresso di un computer in ogni casa, con l’invenzione della sua ‘portabilità’, la diffusione capillare del social networking e il suo utilizzo come mezzo di diffusione di idee capaci di unire e movimentare dentro e fuori i confini nazionali.
Tuttavia, credo che un’interpretazione di questo tipo dia luogo a tre misunderstanding semantici:
- l’avvento del digitale è una rivoluzione dell’umano in senso biologico: dall’invenzione del personal computer alla diffusione contemporanea dell’Internet of Thing – soprattutto se considerata dal punto di vista degli ‘wearables’ – il digitale può essere interpretato come una rivoluzione in senso biologico, ovvero come l’apparizione di un nuovo modo di intendere l’umano, contaminato dall’intelligenza artificiale, connesso attraverso applicativi tecnologici a un mondo virtuale generato dall’interazione di quegli stessi oggetti fra loro e dall’elaborazione dell’enorme quantità di dati che continuamente raccolgono;
- l’avvento del digitale è una rivoluzione generazionale: la diffusione dei social network, l’età e lo stile di vita dei loro ‘inventori’, nonché i linguaggi e le ‘maniere’ di comunicazione utilizzate su queste piattaforme hanno alimentato l’idea dell’improvvisa apparizione di un’intera generazione, i ‘digital natives’, pronti a prendere pieno possesso della nuova epoca, lasciando indietro i cosiddetti ‘digital immigrants’, con le loro difficoltà di adattamento, vecchie abitudini, dubbi e paure;
- l’avvento del digitale è una rivoluzione politica: l’utilizzo delle piattaforme di social networking a supporto di movimenti di protesta politico-sociale – prima su tutti la Primavera Araba e, in particolare, la rivoluzione egiziana (gennaio-febbraio 2011) – ha alimentato le supposizioni circa l’avvento di una nuova forma di democrazia, partecipata e trans-nazionale, resa possibile dalla presenza stessa delle nuove tecnologie; in questo senso, l’apporto rivoluzionario del digitale consisterebbe nel suo duplice ruolo di risorsa per un nuovo tipo di democrazia, ma anche di spazio democratico di per sé stesso.
L’interpretazione biologica, generazionale e politica del digitale condividono una cornice di senso in cui l’avvento del digitale costituisce una rivoluzione disruptive: un’innovazione così potente che può mettere a repentaglio statement consolidati nel brevissimo periodo. La sua rapidità e la portata del suo impatto sono il risultato di tecnologie ‘devastanti’ che entrano di continuo nel mercato con il vantaggio di incontrare consumatori pronti a sfruttarne al massimo le potenzialità e accoglierne i rapidi aggiornamenti. Dà da pensare, a questo proposito, che quando nel 2012 Apple ha rilasciato una nuova versione di software per i suoi dispositivi, gli utenti l’hanno scaricata più di dieci milioni di molte nelle prime quarantott’ore.
Ma è un’interpretazione che, presa da più vicino, non convince fino in fondo.
Innanzitutto, il tema dell’integrazione fra i dispositivi digitali e la loro elaborazione intelligente di un mondo virtuale di dati in grado di descrivere perfettamente l’utente – il suo stile di vita, le sue abitudini, persino il suo modo di pensare e le sue opinioni – è oggi largamente dibattuto.
La ribalta guadagnata dai Big Data e dalla conseguente analisi ‘automatica’ e ‘non supervisionata’ è già minacciata dalla più complessa questione su come ottenere dati che risultino davvero informativi: se i sistemi automatici basati sulla A.I. sembrano perfettamente in grado di misurare il ‘sentiment’ degli utenti – per esempio misurare quante volte viene utilizzato su Twitter il termine ‘Ipad’ –, questi non si dimostrano altrettanto efficaci quando si tratta di tracciare le ‘opinioni’ espresse.
Prendiamo un tweet come ‘I like iPad because it has large screen, but I won’t buy it as it is to expensive’. Dal punto di vista del sentiment, il tweet dev’essere conteggiato fra quanti esprimono un’inclinazione positiva nei confronti del tablet – l’oggetto è citato –, ma dal punto di vista dell’opinione è evidente la sua negatività: l’utente, di fatto, non acquisterà il prodotto di cui parla.
Un caso eclatante sono state le ultime elezioni americane: Obama poteva contare su 16,8 milioni di follower sui diversi social network, mentre Romney aveva un seguito di 0,6 milioni di persone. Eppure lo scarto di voti alle elezioni 2012 fu del solo 3,2% a favore del democratico. Ancora, dall’analisi del sentiment espresso online (soprattutto su Twitter), l’attuale Presidente avrebbe dovuto vincere con un sonoro + 15%, ben lontano dal vero risultato finale, quel 3,2% già citato.
Alla base di uno scarto così ampio sta il fatto che l’analisi dei dati, se effettuata in automatico e non supervisionata, classifica fino al 90% delle informazioni come neutrali, anche se in realtà non lo sono. Diversamente, la supervisione umana consente di effettuare lo switch dal sentiment all’opinione vera e propria, consentendo di individuare il significato dei dati.
Al contrario, nelle elezioni 2008 – che di fatto accesero l’occhio di bue sulla questione Big Data – Nate Silver di FiveThirtyEight pubblicò delle previsioni sulla percentuale di scarto fra i due candidati sostanzialmente allineate ai risultati finali. Questo perché non si era ancora estremizzato l’approccio ‘automatico’ all’analisi, in favore di una forte presenza della componente umana di cabina di regia.
L’integrazione fra i dispositivi digitali e la loro elaborazione intelligente di un mondo virtuale di dati, in grado di descrivere perfettamente l’utente, non è quindi l’inizio di una rivoluzione destinata alla supremazia dell’intelligenza artificiale, ma ribadisce l’importanza di un’integrazione forte fra tecnologia e innovazione people-driven.
Per quanto riguarda l’interpretazione generazionale delle rivoluzione digitale, che vede i ‘digital natives’ contrapporsi ai cosiddetti ‘digital immigrants’, recenti ricerche hanno evidenziato che l’utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale e di social networking è alquanto diffuso anche nella generazione degli Over55, sebbene con sue caratteristiche peculiari.
In altre parole, ciò che più distingue nativi e immigranti digitali non è la frequenza o la capacità di utilizzo degli strumenti, quanto la modalità con cui a quegli stessi strumenti viene effettuato l’accesso: l’avvento della tecnologia mobile ha infatti condotto la generazione Over55 a un leap frog per cui molti di loro pur non utilizzando o avendo in casa un personal computer, accedono ai social network e alla rete in generale da smartphone o tablet.
Si tratta, d’altra parte, della generazione che ha iniziato a utilizzare i primi telefoni cellulari immessi sul mercato e le prime agende elettroniche; a suo agio, quindi, con questa tipologia di device e la loro evoluzione, più che con il personal computer – spesso usato soltanto sul luogo di lavoro.
Nessuna contrapposizione quindi, ma un differente approccio, caratterizzato più dall’incontro fra sviluppo di una particolare tecnologia e ‘habitus’ storico-culturale che va a caratterizzare in maniera specifica purpose e diffusione di comportamenti in due generazioni diverse.
Riguardo all’interpretazione politica dell’avvento del digitale, non mi soffermo qui sull’ampio dibattito ancora in corso sulla relazione fra nuovi strumenti di comunicazione di massa e democrazia; un dibattito che, in ogni caso, più che sulla dimensione comunitaria delle relazioni intrecciate tramite il web 2.0 si concentra invece sulla contrapposizione fra lettura positiva vs. critica di quella che viene definita come una comunicazione massiva di sé o individualismo connesso.
L’idea, in generale, del digitale come risorsa per un nuovo tipo di democrazia – o spazio democratico di per sé stesso – è già a livello di studi accademico-teorici considerata abbastanza debole, in favore di una più forte caratterizzazione dell’epoca che stiamo vivendo come di un’era post-democratica in cui l’individuo e non la collettività ha guadagnato visibilità e importanza.
Tornando poi sul tema della Primavera Araba e sull’utilizzo delle piattaforme di social networking a supporto, i dati concreti raccolti dal Cairo Institute for Human Rights Studies rivelano che questi furono utilizzati attivamente soltanto da una minoranza dei partecipanti alla protesta egiziana – una percentuale infinitesimale della popolazione nazionale. In altre parole, «digital media was not dominant in Egyptian protest activity».
Anche l’analisi dei dati relativi all’utilizzo dei social media oltre i confini nazionali indicano la forte presenza di un piccolo gruppo di power user che esprimevano opinioni e riportavano un’interpretazione dei fatti e una larga audience di utenti passivi – che condividevano e rilanciavano i contenuti prodotti da pochi altri –.
Più che la costruzione conversazionale e online di un movimento di protesta, la cui partecipazione e consapevolezza andava emergendo dal basso grazie agli strumenti online, si trattò quindi della diffusione nazionale e trans-nazionale di empatia e supporto a idee e descrizioni di avvenimenti frutto della capacità comunicativa di alcuni – con una logica, a ben vedere, molto più top-down di quello che altre letture, più entusiaste, vorrebbero ammettere.
Riassumendo: l’interpretazione biologica, generazionale e politica che vede l’avvento del digitale come una rivoluzione disruptive non convince e, soprattutto, non sopravvive a uno sguardo più attento.
Eppure, basta aggiungere un elemento agli highlight che la lettura del Times ha posto sulla timeline della diffusione del digitale per accedere a una nuova e più convincente prospettiva: se nel 1982 la nomination di ‘Person Of The Year’ va al personal computer, e nel 2010 a Mark Zuckerberg, nel 2006 la rivista ci indica un personaggio che ciascuno di noi conosce piuttosto bene:
YOU
Fatta una sostituzione e tenendo conto dell’ordine temporale con cui gli highlight vengono portati a evidenza, ci troviamo di fronte a un’interpretazione dell’avvento del digitale che può essere così riassunta:
- la tecnologia al centro – Personal Computer
- l’utente al centro – You
- le relazioni al centro – Mark Zuckerberg, cioè Facebook
Il tempo che scorre dal punto 1 al punto 3 assiste al cambio di protagonista al centro della scena.
Anche con questa lettura ci troviamo di fronte a una rivoluzione, ma intesa in senso copernicano: gli elementi in gioco non vi si intromettono in maniera ‘devastante’, non agiscono sugli statement consolidati mettendoli a repentaglio, ma spostandone il punto di fuga dando luogo a prospettive differenti.
A differenza di quanto descriveva l’interpretazione disruptive, la rivoluzione ha qui l’aspetto di una trasformazione. Trasformazione in cui l’environment digitale in cui siamo ormai immersi cambia forma – appunto – ruotando la posizione dei suoi fattori sostanziali ma tenendoli sempre in gioco come elementi eterogenei di un tutto organico, una rete che il tempo rivela come fortemente caratterizzata dall’intreccio delle relazioni al suo interno. Un dispositivo, insomma.
Questa interpretazione della rivoluzione digitale come trasformazione è d’altra parte perfettamente in linea con quanto accaduto a seguito dello scoppio della ‘Bolla Dot Com’ del 2001, quando molte delle organizzazioni incumbent nel mercato del World Wide Web assistettero quasi inermi al proprio crollo in borsa.
Soltanto alcune di esse seppero risalire la china senza scomparire. Amazon su tutte, che vide precipitare le proprie azioni da 107 a 7 dollari nel 2001 per poi raggiungere, nei dieci anni successivi allo scoppio della bolla, quota 200. Il guru per eccellenza del web 2.0, Tim O’Reilly, si accorse subito che la sopravvivenza di alcune aziende e la scomparsa di altre era da attribuire alla capacità delle prime di comprendere che c’era una trasformazione in atto, che il web stava passando dalla versione 1.0 alla successiva:
Il principio centrale che sta dietro il successo dei giganti nati nell’era del Web 1.0 che sono sopravvissuti per guidare l’era del Web 2.0 sembra essere questo: l’hyperlinking (la relazione in linguaggio informatico) è il fondamento del web. Quando gli utenti aggiungono nuovi concetti e nuovi siti, questi vengono integrati alla struttura del web dagli altri utenti che ne scoprono il contenuto e creano link. Così come le sinapsi si formano nel cervello, con le associazioni che diventano più forti attraverso la ripetizione o l’intensità, le connessioni nel web crescono organicamente come risultato dell’attività collettiva di tutti gli utenti del web.